Il Gusto della Sua Cura
Il Gusto della Sua Cura' can be condensed to 'Taste of Your Care'.
Il giorno in cui è morta mia nonna a Pechino, sono uscita a cena a New York. Il pasto era dedicato alla sua memoria, ma in realtà parlava della pochezza della mia. Il mio compagno mi chiese delle storie mentre guidavamo da Brooklyn a Flushing, un quartiere che brulicava con la lenta coreografia pedonale della sua predominante diaspora cinese. Guardando un gruppo di nonne dai capelli grigi, indistinguibili a distanza, mi resi conto di non avere storie sulla donna che mi aveva cresciuta. Non conoscevo né la sua età né la città di nascita; né potevo ricordare una singola conversazione condivisa. Mi ha cresciuto fino all’età di quattro anni, un periodo di tempo non impresso nella memoria cosciente. Vuota di aneddoti e lacrime, credevo di essere anch’io vuota, priva di dolore per una donna che avevo visto solo tre volte nei trent’anni precedenti.
Cosa avevo: l’impressione della sua cucina salata e marrone.
Al ristorante, coprimmo il nostro tavolo con cibo del nord della Cina. Costine di maiale e patate, peperoncini amari, intestini brasati. Le torte di carne emettevano un vecchio vapore quando venivano aperte. Di tanto in tanto, aggiungevo un piatto che vedevo arrivare all’unico altro gruppo che cenava alle 16:00 di un giovedì. Tre anziani uomini cinesi diventavano sempre più rumorosi mentre bevevano Tsingtao, le loro erre di Pechino risuonavano, aspre e distintive, nella sala. Conoscevano la lingua e la cucina come io no; sembravano contenti, mentre io no. Il cibo era solo sufficiente.
“Sufficiente”, avrei detto per mesi, quando mi chiedevano come mi sentissi riguardo a mia nonna.
Settimane dopo, quando mi colpì una seconda voglia, ordinai carne di maiale e patate da un posto diverso. Il cibo era, ancora una volta, deludente. Quando un terzo o quarto cartone di costine arrivò sulla mia porta alcuni mesi dopo, aprii la borsa di carta calda e mi resi conto: avevo sbagliato l’ordine. Quello che pensavo fosse fame era una forma mal tradotta di dolore.
- Karl Ove Knausgaard L’uomo, il mito, la leggenda
- Kate Middleton ha aggiunto un sorprendente tocco anni ’70 a u...
- Può Dune salvare il mondo?
Quiz: di’ “dolore” in mandarino. Di’ “dissociazione”. Di’ “inarticolazione”. Di’, con un perfetto accento di Pechino, “la sensazione di aver riposto, nel posto sbagliato, un piccolo oggetto usurato che non riesci più a ricordare; e che comunque non riconosceresti se trovato.” Buona fortuna a superare questo quiz all’età in cui mi sono trasferita dalla casa di mia nonna, ancora inciampando nei blocchi rudimentali di un vocabolario per bambini. Ho perso sempre più di quei pezzi nei trasferimenti in Kentucky, California, Rhode Island, Regno Unito, Thailandia, Iowa, New York. A trentadue anni, mi sono ritrovata senza una lingua da nonna. Potevo esprimermi solo attraverso questo grido primordiale: quello di un bambino che chiede di essere nutrito.
Scontenta dei ristoranti, ho deciso di ricreare la cucina di mia nonna da sola. In questo sforzo, avevo una baldanza improvvisata ereditata da suo figlio, mio padre, un uomo sprezzante delle ricette. Il nucleo della mia formazione culinaria è stato tratto dall’osservazione di mio padre muoversi in rapidi archi digressivi intorno alla stufa. Nella vita, la sua risposta a “quanta sale?” era mettere un po’ di impasto di polpette crude in bocca, sputarlo e aggiungere un altro spruzzo di salsa di soia alla ciotola. (Di’: “intossicazione alimentare” in mandarino.) È morto dieci anni fa.
Per mesi, ho letto blog di cucina e libri di ricette che hanno dato alla mia intuizione la legittimità del linguaggio. L’idratazione è il metodo con cui la carne di maiale macinata viene spruzzata con A) la salsa di soia di mia nonna, B) il vino da cucina di mio padre, o C) l’acqua dei miei shiitake. Carne e liquido, ho imparato, non devono essere mescolati troppo, perché sei A) artritico, B) di fretta, o C) eviti il rilascio di miosina, che indurisce le proteine. Lascia riposare questo per il tempo che ci vuole per A) spostare i mobili in un appartamento affollato di Pechino, B) chiamare i bambini a cena, o C) sentire lo scatto del cronometro, esattamente trenta minuti dopo, sul mio telefono.
Ricerca, incroci di dati e obbedienza alle leggi della scienza alimentare, ho idratato, alla perfezione, il ricordo della zuppa di polpette che mio padre aveva imparato a fare da mia nonna. Stavo accanto al mio pentolino come una guardia del corpo. Raccoglievo ogni sfera grassa e irregolare mentre affiorava. Le polpette, divise, erano così umide e rosa da sembrare crude. Gelatinose, succulente, si rivelarono migliori di quelle di mio padre.
In penitenza per questo pensiero, mangiai la polpette del giorno successivo direttamente dal frigorifero. Fredde e dense, avevano un sapore più vicino alla ricetta di famiglia. Ma ancora non era giusto.
Cosi è trascorso un insolito, tranquillo estate di frenesia sotterranea che si è insinuata nelle fresche settimane grigie dell’autunno. Mi chiudevo in casa per giorni con costine di cumino elaborate e a più fasi; oppure mi addormentavo sfocata alle quattro del mattino, stringendo un telefono che brillava con selezioni di paste di fagioli invecchiate. Metodicamente, ossessivamente, cercavo nuovi ristoranti cinesi del nord su nuove app di consegna di cibo cinese: più incomprensibili erano i menu, meglio era – fino a quando un giorno, il mio compagno mi ha chiesto cosa volessi ordinare per cena.
“Qualsiasi cosa tu voglia”, ha detto.
Voleva tranquillizzarmi. Per mesi, A aveva assaggiato i miei esperimenti e ne aveva elogiato i successi mentre elencavo i fallimenti; sapeva che avevo creato mappe dettagliate di cibi speciali in un raggio di cinquanta miglia e sapeva come usavo quella conoscenza per ridurre le sue opinioni culinarie opposte. Stava cedendo il campo. Avrei dovuto essere entusiasta. Invece, scoppiavo in lacrime.
“Non voglio scegliere”, dissi. “Voglio che tu cucini per me.”
Mi ha ricordato che non era un bravo cuoco, parole uscite dalla mia bocca stessa. Ero quasi altrettanto poco generosa riguardo alla cucina degli altri quanto lo ero riguardo alla mia. Quella notte, non mi importava. Non ho memoria di cosa A mi abbia preparato. Solo come mi ha fatto sentire.
È stato solo scrivendo questo che ho ricordato: mia nonna non era una brava cuoca. Incastonata tra mio padre (lodato) e mia bisnonna (leggendaria), era considerata un’intrusa maldestra in cucina, fortunata a servire un marito troppo preoccupato per la scienza per notare cosa mangiava – oltre a me, un bambino. Pensandoci, sembra possibile che la zuppa di pollo che mia nonna faceva bollire per me con sale e pepe bianco, nient’altro, fosse insipida; che i suoi gnocchi fossero troppo scuri e salati; che io potessi essere una cuoca migliore di lei.
Ogni pasto, ogni giorno, portava con sé l’immensa pressione di definire chi volevo essere.
Certo, mi sono plasmata in un’ingorda mangiatrice più esigente. Ho passato i miei vent’anni alla ricerca del pasto perfetto. Mentre i miei coetanei sceglievano l’educazione continua in cocktail, arrampicata, Settlers of Catan e spagnolo, io imparavo amuse-bouche, reazione di Maillard, gastrique e agrodolce con l’intensità di un bambino immigrato determinato a superare l’inglese come seconda lingua. Con un reddito disponibile appena acquisito, mi sono trovata sedotta tanto dalla cucina raffinata quanto dalla cultura che rappresentava: una certa stratificazione socioeconomica di cosmopolitismo di ispirazione europea espressa in tovaglie bianche, porzioni ridotte e buon gusto – le stesse parole usate per descrivere le dimensioni intellettuali di quella vita in cui i libri sul tavolo sono vecchi e venerati come il vino. Avevo passato anni a guardare attraverso la finestra. Mangiare era, suppongo, il modo più diretto per interiorizzare ciò che desideravo.
Sono diventata un’ingorda insopportabile. Molto prima di criticare la cucina del mio compagno a New York, ho litigato con un amico in una cucina troppo calda a Nashville. N ed io eravamo ventenni, studenti di medicina e scrittura, litigando a livelli assurdi e incendiari su quando aggiungere l’aglio alle verdure. Eravamo ossessionati dall’idea di una sola, migliore opzione. Ora posso capire quanto eravamo infelici nel nostro perfezionismo. Tutto sembrava scarso, allora: prodotti costosi del mercato contadino; borse di studio per studenti; fiducia nei programmi di laurea destinati a portarci nelle vite che volevamo; speranza che quelle vite rimanessero possibili; il tempo stesso in quell’anno claustrofobico. Nel 2016, la fame era diventata un’altra parola per la paura. In me c’era frenesia per l’idea di non aver vissuto abbastanza, fatto abbastanza, consumato le mie porzioni legittime. Ogni pasto, ogni giorno, portava con sé l’immensa pressione di definire chi volevo essere.
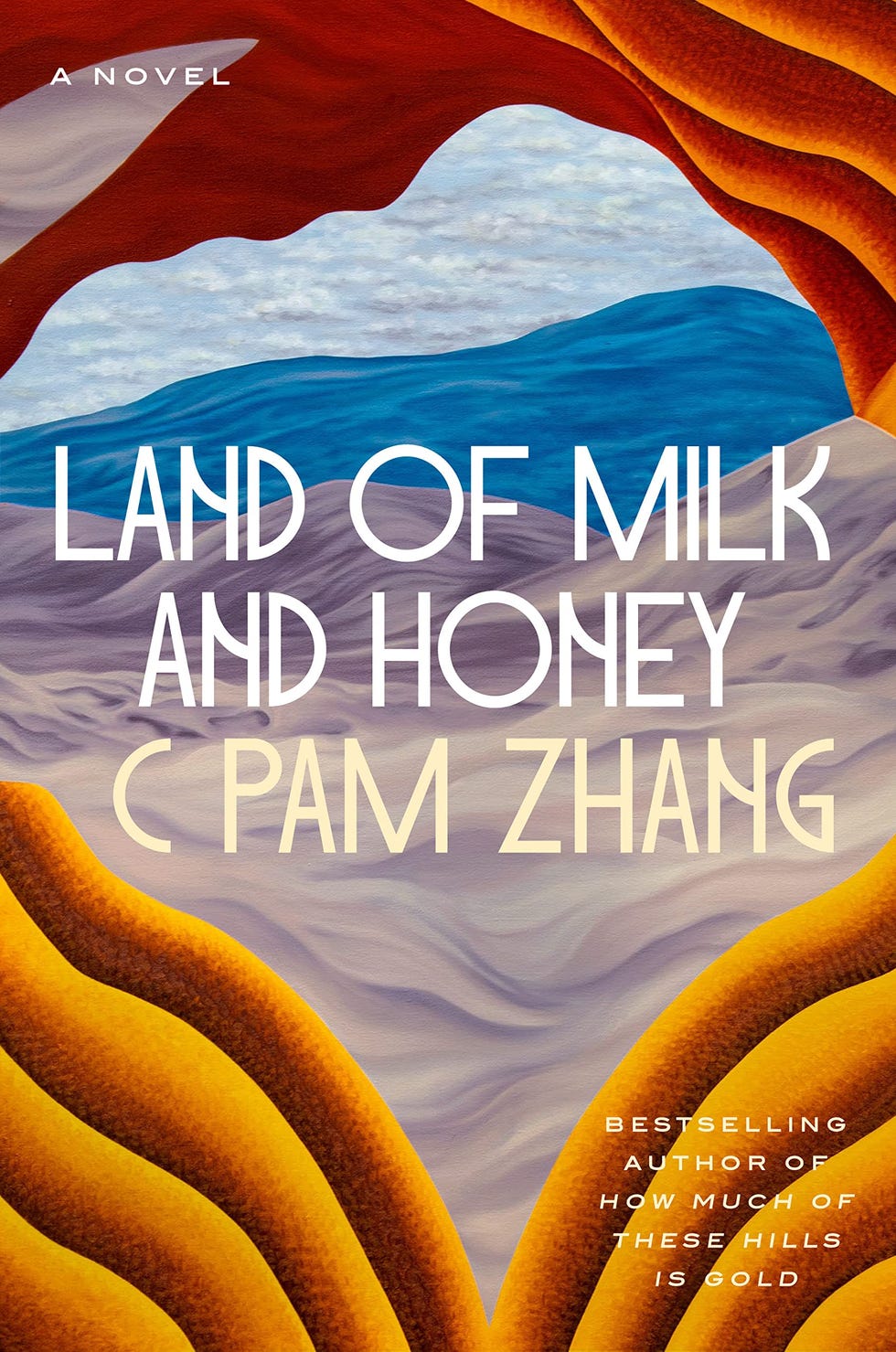
Oggi vivo in un luogo più vasto nel suo paesaggio epicureo e anche emotivo. Sto cercando di coltivare la fiducia nell’abbondanza. Nei cupi anni del 2020 e del 2021, ho desiderato biografie: storie di artiste donne per le quali lunghi periodi di siccità di dolore e penuria, guerra e rottura del cuore non potevano offuscare la fecondità delle loro vite. Il romanzo che ho scritto dopo quegli anni, “La Terra del Latte e del Miele”, è incentrato su uno chef che, alla fine della sua vita, guarda indietro a come ha vissuto durante la carestia. Non sono religiosa – sono un’edonista, infatti – ma questa è la fede che cerco di mantenere. Possa io credere che queste cose passeranno: una settimana di fumo da incendi, quattro anni di politica crudele, una cena scadente, una notte amara; possa io credere in un futuro che conceda il tempo di gustare di più. I miei pasti, liberi dalla paura che può mascherarsi da perfezione, sono spesso cose semplici.
Spesso, ciò che voglio è mangiare male. Ho voglia del broccolo molle di mia madre, poco salato per preoccupazione per la mia pressione sanguigna. La pappa di banane grumose che A ordina dal ristorante giamaicano, così torno a casa con vaschette di plastica calde e i guaiti di un cucciolo. Sei chili di pane mediocre inviati da amici in un’altra città che hanno frainteso le dimensioni di una pagnotta, e il pane tostato francese che un altro amico prepara con le fette raffermo. Io e l’amica K siamo così vicine da ridere dell’assoluta mediocrità delle nostre tostate e andare in cerca di una bottiglia di aceto balsamico antica. Mescoliamo i residui alle ciliegie troppo mature, creando una marmellata di cui non condividerò la ricetta e che non consiglio a nessuno di mangiare di nuovo, ancora – il che la rende unica nel suo genere.
Sembra crudele aver imparato questa lezione così tardi, dopo aver perso il sapore della pasta della nonna e la capacità di chiedere cosa, esattamente, mio padre mettesse nel suo bing; ma mi ricordo che ho smesso di ottimizzare i pasti in una faticosa e impossibile ricerca della perfezione; che ciò che mi è stato dato da mangiare conta meno di ciò che sono stata, da persone che mi amavano. Penso al chai che un’amica mi ha preparato quando ero in lutto per mia nonna. S ha portato il suo tè. Ha usato il latte che c’era nel mio frigorifero. Chai non era una parola nel vocabolario di mia nonna, eppure sono stata colpita dalla familiarità del tè debole che S ha preparato nella mia cucina inadeguata. Insipido, tenero, tiepido, emanava un calore dolce e rameo che non si può comprare. Più profondo delle spezie, più pungente del tè, dimenticato quanto ricordato, come le ciocche secche dei capelli di mia nonna tra le dita, questo era il sapore della sua cura. Per favore, dammi cibo scadente fatto da una persona che mi ama.
C Pam Zhang è un’onorata del National Book Foundation 5 Under 35 e l’autrice premiata di How Much of These Hills Is Gold. Il suo secondo romanzo, Land of Milk and Honey, sarà pubblicato il 26 settembre.






